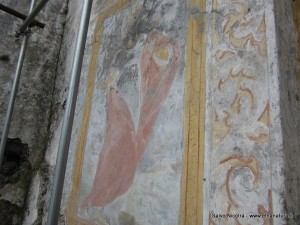Venne realizzato per volere della famiglia Paternò Castello principi di Biscari a partire dalla fine del Seicento e per gran parte del secolo successivo, in seguito al catastrofico terremoto dell’11 gennaio 1693. Il nuovo palazzo venne edificato sulle mura di Catania, costruite per volere dell’imperatore Carlo V nel Cinquecento e che avevano in parte resistito alla furia del terremoto: i Biscari furono una delle poche famiglie aristocratiche della città che ottenne il permesso regio di costruire su di esse. La parte più antica del palazzo fu costruita per volere di Ignazio, terzo principe di Biscari, che affidò il progetto all’architetto Alonzo Di Benedetto, ma fu il figlio di Ignazio, Vincenzo, succeduto al padre nel 1699, a commissionare la decorazione dei sette splendidi finestroni affacciati sulla marina, opera dello scultore messinese Antonino Amato. Successivamente il palazzo fu modificato per volere di Ignazio Paternò Castello, quinto principe di Biscari, il quale lo fece ampliare verso est su progetto di Girolamo Palazzotto e, successivamente, di Francesco Battaglia. L’edificio venne infine ultimato nel 1763 ed inaugurato con grandiosi festeggiamenti. Al palazzo si accede attraverso un grande portale su via Museo Biscari, che immette nel cortile centrale, adorno di una grande scala a tenaglia. All’interno, si trova il “salone delle feste”, di stile rococò dalla complessa decorazione fatta di specchi stucchi e affreschi dipinti da Matteo Desiderato e Sebastiano Lo Monaco. Il cupolino centrale era usato come alloggiamento dell’orchestra, ed è coperto da un affresco raffigurante la gloria della famiglia Paternò Castello di Biscari. Si accede alla cupola attraverso una scala decorata a stucco (che il principe Ignazio chiamò “a fiocco di nuvola”) all’interno della grande galleria affacciata sulla marina. Tra le altre sale vanno ricordate quella “dei Feudi”, con alle pareti grandi tele rappresentanti i numerosi feudi dei Biscari; gli “appartamenti della principessa”, costruiti da Ignazio V per la moglie, Anna Morso e Bonanno dei principi del PoggioReale, con boiseries di legni intarsiati e pavimenti di marmo di epoca romana; la “galleria degli Uccelli” e la “stanza di don Chisciotte”. Infine particolare importanza riveste il Museo, dove un tempo era raccolta la grande collezione archeologica (oggi in parte al Museo civico del castello Ursino) di Ignazio V, grande studioso, archeologo e amante delle arti in genere. Tra i celebri visitatori del palazzo si ricorda soprattutto lo scrittore Johann Wolfgang Goethe che, nel corso del suo viaggio in Italia, venne ricevuto dal principe di Biscari il 3 maggio 1787, poco dopo la morte del padre Ignazio. Agli inizi del 2008 il palazzo ha fatto da sfondo al videoclip della canzone Violet Hill della band inglese Coldplay.
Venne realizzato per volere della famiglia Paternò Castello principi di Biscari a partire dalla fine del Seicento e per gran parte del secolo successivo, in seguito al catastrofico terremoto dell’11 gennaio 1693. Il nuovo palazzo venne edificato sulle mura di Catania, costruite per volere dell’imperatore Carlo V nel Cinquecento e che avevano in parte resistito alla furia del terremoto: i Biscari furono una delle poche famiglie aristocratiche della città che ottenne il permesso regio di costruire su di esse. La parte più antica del palazzo fu costruita per volere di Ignazio, terzo principe di Biscari, che affidò il progetto all’architetto Alonzo Di Benedetto, ma fu il figlio di Ignazio, Vincenzo, succeduto al padre nel 1699, a commissionare la decorazione dei sette splendidi finestroni affacciati sulla marina, opera dello scultore messinese Antonino Amato. Successivamente il palazzo fu modificato per volere di Ignazio Paternò Castello, quinto principe di Biscari, il quale lo fece ampliare verso est su progetto di Girolamo Palazzotto e, successivamente, di Francesco Battaglia. L’edificio venne infine ultimato nel 1763 ed inaugurato con grandiosi festeggiamenti. Al palazzo si accede attraverso un grande portale su via Museo Biscari, che immette nel cortile centrale, adorno di una grande scala a tenaglia. All’interno, si trova il “salone delle feste”, di stile rococò dalla complessa decorazione fatta di specchi stucchi e affreschi dipinti da Matteo Desiderato e Sebastiano Lo Monaco. Il cupolino centrale era usato come alloggiamento dell’orchestra, ed è coperto da un affresco raffigurante la gloria della famiglia Paternò Castello di Biscari. Si accede alla cupola attraverso una scala decorata a stucco (che il principe Ignazio chiamò “a fiocco di nuvola”) all’interno della grande galleria affacciata sulla marina. Tra le altre sale vanno ricordate quella “dei Feudi”, con alle pareti grandi tele rappresentanti i numerosi feudi dei Biscari; gli “appartamenti della principessa”, costruiti da Ignazio V per la moglie, Anna Morso e Bonanno dei principi del PoggioReale, con boiseries di legni intarsiati e pavimenti di marmo di epoca romana; la “galleria degli Uccelli” e la “stanza di don Chisciotte”. Infine particolare importanza riveste il Museo, dove un tempo era raccolta la grande collezione archeologica (oggi in parte al Museo civico del castello Ursino) di Ignazio V, grande studioso, archeologo e amante delle arti in genere. Tra i celebri visitatori del palazzo si ricorda soprattutto lo scrittore Johann Wolfgang Goethe che, nel corso del suo viaggio in Italia, venne ricevuto dal principe di Biscari il 3 maggio 1787, poco dopo la morte del padre Ignazio. Agli inizi del 2008 il palazzo ha fatto da sfondo al videoclip della canzone Violet Hill della band inglese Coldplay.
Da Wikipedia
Foto di Salvo Nicotra
Sito Etnanatura: Palazzo Biscari.